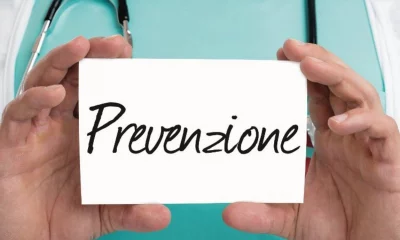Approfondimenti
Sanità, come paghi mangi
Il Servizio Sanitario Nazionale sta perdendo una delle caratteristiche distintive e il suo punto di forza: l’accesso universalistico. Di contro, l’incapacità della sanità pubblica di far fronte alla richiesta di prestazioni mediche ha favorito il proliferare di struture convenzionate o del tutto private. Interviste all’assessore regionale Rocco Palese, all’ex direttore dell’Asl Lecce Franco Sanapo (oggi medico della Direzione Sanitaria della Clinica San Francesco di Galatina) ed a Suor Margherita Bramato, direttrice generale dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase

di Giuseppe Cerfeda
Complice anche l’innalzamento dell’aspettativa di vita, negli ultimi anni è aumentata a dismisura la richiesta di prestazioni sanitarie a fronte di una sempre maggiore difficoltà da parte della sanità pubblica di soddisfare la domanda. Conseguenza quasi fisiologica di tale quadro, il proliferare di cliniche, case di cura, centri medici, poliambulatori specialistici privati e/o convenzionati. Questo è accaduto
su tutto il territorio nazionale ed il Salento non fa eccezione.
L’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, conferma la paresi del servizio pubblico nazionale: «La parte pubblica è enormemente burocratizzata. Chi ha bisogno è costretto a prendere appuntamento con il medico di base; stabilito che ha bisogno di una visita specialistica, dovrà andare al Cup per la prenotazione; dopo la visita specialistica dovrà rifare la trafila per il referto… Mbah, uno si fa quattro conti: se per una radiografia, ad esempio, con 40 euro si riesce in un giorno a fare tutto, vale la pena perdere tempo dietro la sanità pubblica? Senza contare il problema delle liste d’attesa e quindi del tempo che il paziente dovrà aspettare prima di poter finalmente soddisfare i suoi bisogni».
«Come forse mai accaduto prima», ammette Palese, «il servizio sanitario pubblico sta attraversando una fase di profonda crisi rispetto alla sua caratteristica principale che è l’accesso universalistico alle prestazioni, che dovrebbero essere garantite dalla parte pubblica perché non tutti si possono permettere quella spesa per curarsi».
L’assessore regionale evidenzia poi un altro aspetto: «Pur essendo la nostra una provincia a bassa capacità fiscale, con poco reddito, anche da noi si sta diffondendo il fenomeno delle assicurazioni. Prendiamo ad esempio i dentisti: un congruo numero, almeno il 30% dei pazienti che si rivolgono a loro per curarsi, hanno l’assicurazione».
Secondo Palese, sono diverse le cause che stanno determinando l’aumento dell’offerta privata al netto del servizio pubblico: «Innanzitutto vi è stata un’impennata dopo il Covid che ha molto sensibilizzato sulla necessità di screening, controlli cardiologici, ecc. Poi ci sono ragioni di natura diversa che riguardano l’invecchiamento della popolazione che quindi abbisogna di più di cure mediche. Non solo, un ruolo importante lo riveste anche l’aumento dei pazienti cronici. Una volta la cronicità riguardava per la stragrande maggioranza persone con handicap, con malattie rare o diabetici. Oggi, anche grazie allo sviluppo delle cure oncologiche l’aspettativa di vita in media, è più alta. Così come ci sono più opportunità di sopravvivere ad un infarto o ad altre patologie. Grazie a Dio direi oggi si vive di più. Tradotto, però, ci sono più malati cronici che devono essere assistiti».
Ci stiamo, forse, americanizzando?
«Sembrerebbe di si e la cosa non mi piace affatto! Il nostro servizio sanitario è considerato tra i migliori del mondo proprio per il suo accesso universalistico. Siamo in un contesto di tempesta perfetta. Il Covid oltre ad aver mietuto vittime, ha terremotato il servizio sanitario pubblico e rimetterlo in piedi è particolarmente difficile perché non abbiamo risorse sufficienti, i medici sono pochissimi e la richiesta di prestazioni cresce a dismisura».
Secondo lei questo è l’inizio della fine della sanità pubblica?
«Guai! Io continuo a crederci. Siamo davanti ad una criticità enorme, la più grande dal 1978, quando è nato il servizio sanitario nazionale, ma dobbiamo reagire, vincere la sfida e riportare la sanità pubblica ai livelli pre-Covid, o superiori».
Anche prima del covid era manifesto il problema delle liste d’attesa che oggi paiono una montagna impossibile da scalare. In tutta Italia sono stati finanziati più di tre miliardi basteranno per arrivare in vetta?
«È una falsità!», tuona Rocco Palese, «positivo l’investimento, ma non dicano che quei soldi servono per abbattere le liste d’attesa: 2,4 miliardi copriranno i costi del rinnovo dei contratti di tutto il personale; 500 milioni riguardano ’applicazione del nuovo tariffario delle prestazioni sanitarie a partire dal 1° gennaio 2024. Per le liste d’attesa restano circa 500 milioni, di cui poco più di trenta (32-34 milioni di euro) arriveranno in Puglia. Una goccia in mezzo al mare».
Franco Sanapo: «Necessaria radicale e coraggiosa riforma del sistema»

Franco Sanapo, medico della Direzione Sanitaria della Clinica San Francesco di Galatina ed ex direttore sanitario dell’Asl Lecce
Sulla questione pubblico-privato nella sanità abbiamo interpellato Franco Sanapo già direttore sanitario dell’Asl Lecce e oggi medico della Direzione Sanitaria della Clinica San Francesco di Galatina che opera all’interno della Clinica dal 2011. La Clinica San Francesco è un ospedale Privato Accreditato (Convenzionato) con il Sistema Sanitario Nazionale. Ha due linee di attività: Ricovero per acuti (60 posti letto per Medicina, Chirurgia Generale, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia e Oculistica), Attività Ambulatoriali (Radiologia, Laboratorio Analisi, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria)
Mi può confermare la tendenza dei cittadini salentini a un ricorso massiccio alle prestazioni a pagamento e, quindi, a un proliferare di strutture private che rispondono a questa domanda di salute?
«Il fenomeno credo sia in linea con l’andamento generale nell’intera nazione. Confermo pertanto l’incremento della spesa sanitaria che i nostri cittadini sopportano di tasca propria non trovando risposte di salute nel sistema pubblico. Confermo anche il proliferare di strutture private, prevalentemente ambulatoriali, che erogano prestazioni sanitarie a pagamento».
Può fornire qualche stima, per inquadrare l’entità del fenomeno?
«Non sono in condizioni di fornire dati provinciali o regionali di quanto spendono di tasca propria i nostri cittadini per curarsi o quante sono le nuove strutture private sanitarie che in questi ultimi anni sono proliferate. Certamente hanno avuto una enorme impennata, basta guardare nei nostri comuni o in quelli vicini per rendersene conto. Il dato nazionale del 2022 indica un esborso da parte dei cittadini – che già finanziano la sanità pubblica e quella convenzionata con l’Irpef – di 41 miliardi e 503 milioni, per circa un quarto (25%) della spesa complessiva che supera i 170 miliardi. Posso tuttavia fornire il trend di crescita della spesa sanitaria a pagamento che rilevo dalla mia postazione lavorativa, che pure ha una attività convenzionata pagata dallo Stato. In un decennio (2012 -2022) le prestazioni ambulatoriali a pagamento hanno avuto un incremento molto rilevante. Non so se in altre strutture convenzionate si sia registrato lo stesso fenomeno, ho tuttavia il sentore che la Clinica sia in numerosa e ottima compagnia».
Perché i cittadini pagano una prestazione sanitaria invece di pretenderla e riceverla da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata?
«Il meccanismo è semplice. Nelle strutture pubbliche le attività ambulatoriali e le radiologie sono prese d’assalto, gli addetti (specialisti e personale infermieristico o tecnico) sono pochi o mal organizzati, le attese sono lunghe, a volte superano i 12 mesi. Nel privato convenzionato la ASL assegna una somma annuale definita e invalicabile. Facciamo l’esempio di una struttura convenzionata per l’attività di endoscopia digestiva (gastroscopia o colonscopia) e ammettiamo che per quelle attività siano assegnati 120 mila euro, che significa, in dodicesimi, 10 mila euro al mese. Accade che intorno alla metà del mese, quello stanziamento è esaurito e non è possibile erogare la prestazione, con la conseguenza che slitta in avanti la data di prenotazione che ha già accumulato prenotazioni del mese precedente. L’effetto delle lunghe liste di attesa nel pubblico è la possibilità, per chi se lo può permettere, al ricorso alle prestazioni a pagamento in favore dei medici specialisti pubblici che erogano Attività Libero Professionali Intramoenia (ALPI) negli ospedali pubblici o negli ambulatori della ASL. L’effetto nel privato: o aspetti mesi e mesi se vuoi fare la visita o prestazione strumentale con la ricetta, oppure paghi e fai subito la prestazione. Da qui il proliferare di strutture di “privato puro”, vale a dire strutture che erogano prestazioni sanitarie solo a pagamento».
Secondo lei quali sono le cause di questo fenomeno in così rapida crescita?
«Le cause sono molte. A partire lo scarso finanziamento pubblico del Sistema Sanitario Nazionale. L’Italia destina poco più del 6,8% del PIL alla spesa sanitaria, al di sotto della media dei paese OCSE (nazioni con le economie più forti) e molto al di sotto della media europea. Se compariamo la spesa delle maggiori nazioni europee vediamo che Francia e Germania destinano alla sanità quasi l’11% del PIL, il Regno Unito circa il 10% e la Spagna il 9%. Ricordo che ogni punto di Prodotto Interno Lordo (PIL) significano miliardi su miliardi.
Il Sistema Sanitario Italiano, poi, è prevalentemente un sistema universalistico inserito nel mare magnum del Pubblico impiego che, come tale, ha sacche di inefficienze che affliggono tutta la pubblica amministrazione.
E ancora: l’inappropriatezza delle prestazioni. Non è un concetto astratto. Significa che se lo stato riconosce tutto a tutti (ti chiami John Elkann o Mario Rossi) gratis ognuno si sente in diritto di ricorrere al sistema a prescindere dalla reale necessità (appropriatezza), ingolfando il sistema già in crisi economica di suo. E, di conseguenza, il collasso dei Pronto Soccorso e le liste di attesa lunghissime per avere una prestazione. Nei sistemi sanitari differenti dal nostro, quelli finanziati non con la tassazione generale (IRPEF), ma con le Assicurazioni Sanitarie Sociali Obbligatorie – Germania, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio e altre nazioni europee – l’efficienza del sistema è superiore e non si assiste a quanto rileviamo in Italia. Se non si mette mano alla riforma del nostro sistema, rendendolo più simile al modello europeo più virtuoso (modello tedesco), puoi mandare a governare la sanità anche il miglior manager del mondo, il fallimento è garantito. Il nostro sistema risponde a una governance di tipo politico (perché amministra i soldi di tutti). Il modello sanitario alla tedesca risponde a una governance di tipo economico. Notoriamente la politica cerca il consenso, le assicurazioni, seppure sociali obbligatorie, cercano l’efficienza e la sostenibilità».
Ci stiamo americanizzando?
«No, per fortuna! Perché siamo inseriti in una cultura europea che ha fatto del Walfare, contro le storture del liberismo selvaggio, il punto di forza e coesione sociale. Ma se non si mette mano alla modifica del sistema sanitario il rischio è elevato: chi può si cura, chi non può aspetta, con tutte le conseguenze in termini di aspettativa e qualità di vita».
L’attuale situazione delle difficoltà dei Pronto Soccorso, letteralmente presi d’assalto, delle lunghe liste di attesa per ricoveri programmati, per visite specialistiche e prestazioni strumentali è sanabile?
«Si attraverso due meccanismi. Il primo: impiegare più soldi (molti miliardi) ogni anno per assumere medici specialisti, personale sanitario e attrezzature, per aumentare i budget delle strutture convenzionate. A ammodernare l’edilizia sanitaria delle strutture pubbliche e fornirle di strumentazione moderna. Il secondo: mettere mano a una radicale e coraggiosa riforma dell’attuale sistema sanitario governato dalla politica e passare a quello europeo, più efficiente. Il primo meccanismo mi pare irrealizzabile perché o si aumentano le tasse (e nessuno lo vuole) o si aumenta il già mostruoso debito pubblico italiano. Il secondo sarebbe possibile se si abbandonano pregiudizi ideologici».
E la nostra Regione che amministra la Sanità con i trasferimenti economici?
«È vittima dei meccanismi che ho descritto prima, perché viene finanziata (male) dallo Stato. Pochi soldi per la sanità, disavanzo economico annuale e inefficienze sono sotto gli occhi di tutti. Con qualunque partito e con qualunque assessore».
Suor Margherita Bramato: «Pubblico e privato devono coesistere»
La premessa di Suor Margherita Bramato, direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera “Cardinale G. Panico” di Tricase, è che «la presenza delle strutture private è una possibilità di libera scelta, per chi vuole e ne ha l’opportunità, di accedere a proprie spese alle prestazioni sanitarie. Riguardo alle strutture convenzionate, invece, ritengo siano necessarie. Sono per il sistema misto perché il pubblico, da solo, non potrà mai reggere. è importante, in una democrazia, l’apporto dei privati, soprattutto quelli no profit che condividono la mission dell’assistenza al paziente e quindi siano di supporto, di integrazione o, addirittura, all’interno delle reti. Il nostro, ad esempio, è un ospedale classificato ed è nelle reti. Quindi, dal punto di vista dei servizi, siamo equiparati al pubblico».
Si teme che si arrivi al punto in cui si potrà curare solo chi ne ha la possibilità economica.
«È una questione di organizzazione. Premesso che la rete dell’urgenza-emergenza segue una sua via di priorità, è chiaro che se manca il personale, che è un dato di fatto oggettivo, il sistema va in tilt. Ci vorrebbe un’organizzazione ferrea e la giusta vigilanza sull’adeguatezza delle prescrizioni, perché la programmazione e l’organizzazione reggano».
Non è anche una questione di risorse?
«Certamente. Perché, come dicevo, soffriamo di carenza di personale, oltre ad essere spesso prigionieri anche di una serie infinite di normative che limitano la disponibilità. Quello che è successo di recente con i medici del pronto soccorso barese, puniti (la sanzione è stata poi annullata, NdA) per aver lavorato troppo durante il covid grida vendetta. C’è una discrasia anche all’interno dell’organizzazione governativa: da una parte si chiede di fare il massimo, dall’altra sorgono questioni particolari come quelle vissute da quei medici. Credo che nella vita occorra trovare il giusto equilibrio. Anche per la questione delle liste d’attesa: il problema è a monte, bisogna lavorare cioè sull’appropriatezza delle prescrizioni e distinguere l’emergenza da tutto ciò che può aspettare. Ad ogni modo, il pubblico da solo non ce la può fare ed è necessaria l’integrazione del privato no profit e di quello convenzionato. L’ideale sarebbe un’integrazione reale, senza paura che uno possa prevalere sull’altro, ciascuno al proprio posto in rete con le risorse che ha e tutti al servizio del paziente. In questo modo avremmo un servizio sanitario nazionale efficiente, armonioso e utile alla popolazione. Ribadisco, però, ci vuole a monte una vigilanza sull’adeguatezza delle prescrizioni, altrimenti non si risolverà mai il problema delle liste d’attesa».
Secondo lei esiste il rischio di un’americanizzazione della nostra sanità?
«Il sistema potrebbe non portare a questo se ben gestito, ben equilibrato e ben vigilato».
Oggi il sistema è ben gestito?
«Secondo me non sempre. Si lavora in emergenza e si cerca di tamponare. Occorrerebbe preventivamente avere una certa organizzazione, personale a disposizione… invece nel servizio sanitario nazionale ci rincorriamo sempre. Anche noi, che facciamo parte della rete, purtroppo siamo costretti a lavorare un po’ così, facendo sempre i conti con la carenza finanziaria».
Quindi i fondi non sono sufficienti…
«Assolutamente! Da 12 anni abbiamo il tetto bloccato. In queste condizioni avremmo dovuto chiudere l’ospedale già da un pezzo! Resistiamo, facendo i salti mortali, solo per rispetto al territorio, ai suoi abitanti e alla mission lasciateci in eredità dal Cardinale Panico. Si dovrebbe anche considerare che negli ultimi 15 anni la sanità ha fatto passi avanti enormi con l’utilizzo della tecnologia, dalle protesi di ultima generazione alla robotica, all’intelligenza artificiale. Tutte cose costose. È anche per questo, oltre ai rincari di cui tutti siamo a conoscenza, che i fondi non possono essere gli stessi di 15 anni fa».
Approfondimenti
Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento
Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.
Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.
Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.
Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.
Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.
Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.
Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.
Si entrerà nel vivo domenica 18.
Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.
Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.
Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.
Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.
Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.
Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.
Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ
Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.
In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.
Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.
Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.
La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.
Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.
Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.
La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.
Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.
Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.
Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.
IL PROGRAMMA RELIGIOSO
10 – 18 GENNAIO – NOVENA
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre
DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA
Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena
Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria
LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO
Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre
Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.
Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono
Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca
IL PROGRAMMA CIVILE
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio
Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.
Stand gastronomici con prodotti tipici.
BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO
Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco
ALTA FREQUENZA LIVE SHOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri
SHOCCHEZZE IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE
Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali
Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio
Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE
Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale
Asta del Santo e dello stendardo
A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO
Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre
Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie
Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
Ore 22:30 – Viale stazione
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro
Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.
Luna Park in Piazza Cuti.
📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
- Il Santo in processione
- Il pittoresco innalzamento dello stendardo
- La pestanaca
Approfondimenti
Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo
Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.
Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.
 Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.
Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.
Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.
Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.
° ° °
 Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.
Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.
Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.
° ° °
I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.
Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.
Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.
Approfondimenti
Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.
La sicurezza e la scelta dei materiali
Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.
L’arte di definire i contorni
L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.
Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti
Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.
L’uso di elementi decorativi a pavimento
Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.
Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo
La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.
Soluzioni pratiche per l’alimentazione
Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.
-

 Alessano4 settimane fa
Alessano4 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti
-

 Attualità7 giorni fa
Attualità7 giorni faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faCosa accadrà alla Piscina di Marina Serra?
-
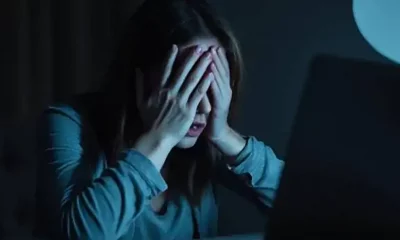
 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane fa“Mia Moglie” su Facebook: il gestore era salentino
-

 Alessano6 giorni fa
Alessano6 giorni faTempesta di vento si abbatte sul Salento, danni e paura a Tricase e Alessano
-

 Alessano3 settimane fa
Alessano3 settimane faSpacciavano da casa, arrestati
-

 Alessano2 settimane fa
Alessano2 settimane faDopo la tragica morte di Giuseppe, il cognato, don Antonio, lo ricorda con una commovente omelia