Approfondimenti
Arte vecchia, scarpe nuove: la scalata della “Zaminga”
L’intervista – “Decollati senza l’aiuto di nessuno: nei nostri confronti totale disinteresse”

Da quasi un anno, nella zona industriale di Tricase, tre bandiere sventolano all’ingresso di un capannone. Sono quella italiana, quella europea e quella degli Emirati Arabi Uniti. Sormontano un cancello che si chiude alle spalle una certezza e un po’ di mistero. In paese lo sanno tutti: lì c’è un calzaturificio. In quel capannone Tricase è tornata a parlare una lingua che conosce, ma che sembrava morta e sepolta. Quello stesso tetto sotto il quale un tempo muoveva i primi passi l’epopea di Adelchi Sergio, oggi è il campo base della scalata dei fratelli Zaminga. È sia punto di arrivo che di partenza di una storia che, a dirla tutta, più che farsi avvolgere dal mistero, si presta al chiacchiericcio per i suoi intrecci col passato. E a Tricase, che a cavallo tra vecchio e nuovo millennio faceva rima con scarpe ed era la terra proprio di Adelchi, non potrebbe essere altrimenti.
“Lui non c’entra nulla. È venuto spesso a trovarci e per questo la gente crede che abbia degli interessi nella nostra attività, ma non è così”. È Guido Zaminga a precisare l’estraneità di Adelchi nell’azienda di proprietà sua e dei suoi fratelli Roberto e Giuliano. È lui a ripercorrere con noi la loro storia, partita in tutti i sensi da lontano. Guido è la personificazione del “self made man”, l’icona del sogno americano del ventesimo secolo, la realizzazione personale dal nulla, attraverso il sudore e la perseveranza. Ha imparato a dare del tu al lavoro, iniziando proprio da ragazzino (quasi bambino per la verità), con i suoi fratelli, a lavorare nella filiera Adelchi che lo ha poi portato fino in Bangladesh (“Quando ci andammo noi non c’erano le comodità di oggi: dormivamo in mezzo ai topi”). Ci mostra il suo lato duro e granitico, come se ad un uomo al comando non fosse concesso sorridere. Poi si scioglie e ci racconta, come farebbe ad un amico, come hanno fatto a metter su una realtà che dà lavoro ad 80 persone.
“Non ci ha aiutati nessuno, siamo arrivati fin qui da soli: gli unici a darci un briciolo di fiducia sono stati amici e conoscenti che ci hanno aiutati ad acquistare i macchinari facendoci credito. Non abbiamo visto il becco di un quattrino dalle banche e nemmeno il minimo sostegno morale dalla politica”.
Nemmeno da quella locale?
“C’è stato un totale disinteresse nei nostri confronti, come dimostra anche l’isolamento che viviamo qui nella zona industriale. Attorno a noi regna il degrado e l’incuria. Non un minimo di illuminazione, di pulizia o anche solo di controllo stradale all’orario di uscita degli operai. Ogni giorno tremo ricordando un incidente che vidi da vicino proprio su questa pericolosa strada tanti anni fa. Cosa costerebbe ai vigili venire a dare un’occhiata al traffico per quei dieci minuti al giorno? Evidentemente la via sotto i riflettori è un’altra (parla dell’altro braccio della zona industriale, quello che conduce alla famigerata maxi rotatoria di Lucugnano), vi hanno fatto un rondò ogni cinque metri! Questo lato invece è diventato un museo abbandonato. La prima domanda che si fa chi viene da fuori è cosa siano questi capannoni dissestati che ci circondano. Io non ci vedo più il passato, ma quello che avrebbero potuto essere”.
Tu cosa ci avresti fatto?
“Una zona industriale gestita dal Comune. Mi viene da ridere a pensare che Tricase ha acquistato l’Acait. Non ho ancora capito a cosa è servita quella spesa. Non sarebbe stato meglio acquistare questi capannoni e ridargli vita? A Corsano, ad esempio, la zona industriale è di proprietà comunale. Per Tricase sarebbe stata una opportunità, non per farvi impianti di compostaggio o chissà che, ma magari per portare in un’area adatta officine e depositi che affollano il paese e per avere un piccolo introito, derivante dagli affitti, nelle casse pubbliche. Senza contare che avrebbe ridato lustro all’intera area. Noi prima eravamo a Tiggiano, dove la zona industriale è un fiore all’occhiello: pulita, ordinata e controllata”.
È da lì che siete partiti?
“No, dall’Albania. Poi siamo rientrati in Italia passando da Miggiano e successivamente da Tiggiano. Fino ad arrivare a Tricase, quasi un anno fa”.
Una scelta di cuore?
“La realizzazione di un sogno. Lavorare e dare lavoro a casa nostra era un obiettivo che avevamo in testa da sempre”.
Al netto dei problemi incontrati, da rifare?
“Senza dubbio sì, probabilmente però sbagliando. Perché in fin dei conti sono a casa, ma mi sento solo. Ci manca anche il semplice appoggio morale. Io non mi sono mai interessato di politica, ma stupisce che tanto il Sindaco quanto gli assessori non si siano mai fatti vivi. Non lo dico per noi, ma almeno per chi ci lavora”.
Che forza lavoro avete?
“Abbiamo 40 dipendenti fissi ed altri 40 impiegati periodicamente. Non possiamo assumere tutti a tempo indeterminato perché anche per noi la certezza del lavoro non è sempre a lungo termine. Poi, paradossalmente, con le leggi odierne si è più agevolati ad assumere chi non ha esperienza che chi è in mobilità. Certo non un aiuto in un periodo così ricco di difficoltà”.
Si mormora in proposito di ritardi nei pagamenti.
“So che circolano voci a riguardo e ci tengo a fare una precisazione: non nascondo che le difficoltà iniziali ci hanno portato a qualche ritardo nei primi periodi. Ma pian piano le cose si sono messe a posto, i nostri operai hanno capito, ci hanno visti crescere ed hanno riposto fiducia in noi, standoci vicini”.
Ad oggi, che fatturato fate?
“Negli ultimi sei mesi abbiamo sfiorato i due milioni di euro”.
E puntate ad espandervi.
“Se mi lasciano stare…(fa riferimento al furto subìto da pochi giorni). Ci hanno rubato un camion e centinaia di paia di scarpe. Un danno da 200mila euro. Non il primo caso: già ad agosto ci avevano fatto ‘visita’. Eppure stavolta ci eravamo assentati solo per qualche ora…”
Non ci aspettavamo una commiserazione, ma a onor del vero nemmeno questa reazione: l’imprenditore non si lecca le ferite, il furto non lo mette in ginocchio. Al più, spiega, “mi fa rabbia, perché pesa sul lavoro delle persone. E fa stizzire ancor di più sentirsi presi in giro da qualcuno come è accaduto subito dopo…”
Allude all’infelice commento su Facebook dell’assessore Sergio Fracasso (“…mi puzza un po’…”) all’accaduto. Episodio che lo ha portato a scrivere una lettera al politico tricasino tramite le nostre colonne (su www.ilgallo.it) e cui lo stesso Fracasso ha risposto chiedendo scusa per la sua uscita “colorita” ma, a suo dire, priva di dietrologia.
“Ci stiamo comunque espandendo”, riprende Zaminga, “abbiamo appena acquistato altri due macchinari da taglio, quelli che ci mancavano per poter fare il prodotto in loco dalla A alla Z, dal disegno della scarpa, fino alla sua forma finale”.
Producete solo qui in Italia?
“Siamo in grado di farlo. In parte però lavoriamo ancora in Albania. Alcune tomaie le facciamo lì, perché richiedono più manodopera”.
E la manodopera costa…
“Non solo. Costa e scarseggia: si è perso quello zoccolo duro che un tempo lavorava per Adelchi. Alcuni suoi ex dipendenti oggi lavorano per noi, altri invece fanno altro o non lavorano più perché avanti con gli anni. La manodopera sapiente che avevano maturato non c’è più. Anche per questo abbiamo in mente di mettere su una scuola per insegnare ai giovani a cucire a macchina”.
Oggi che mercato servite?
“Una fascia medio alta. Lavoriamo con arabi e coreani. Marchi come Capo Italy ed Ecoflex puntano su di noi perché sanno che il Made in Italy offre garanzie che in Paesi come l’Albania non ci sono: lì hanno bisogno di essere monitorati costantemente da tecnici per assicurarsi un lavoro di qualità“. E aggiunge, strizzando l’occhio: “In Italia è tutta un’altra cosa…”
Noi lo avevamo capito da subito, la sua fabbrica lo comunica in ogni angolo. Nella sala dove ci accomodiamo, troneggia un tricolore di forme di calzature in legno, verniciate di bianco di rosso e di verde. La “Z” gigante di Zaminga, che si erge per le pareti dei capannoni, poggia su una piccola bandiera del Belpaese. La stessa che sventola all’ingresso del calzaturificio, la stessa che fa brillare gli occhi di Zaminga quando si parla di casa, di Tricase, di Italia. Perché in fondo quel tricolore è molto più di una garanzia di qualità. È la spinta che riesce a far largo tra le piramidi ed i mausolei di un paese che non sapeva più cosa significa dare lavoro ad 80 persone. È il motore vero che può alimentare la scalata di un “self made man” in un sogno tutto salentino. Altro che American Dream…
Lorenzo Zito
Approfondimenti
Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento
Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.
Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.
Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.
Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.
Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.
Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.
Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.
Si entrerà nel vivo domenica 18.
Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.
Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.
Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.
Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.
Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.
Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.
Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ
Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.
In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.
Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.
Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.
La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.
Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.
Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.
La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.
Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.
Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.
Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.
IL PROGRAMMA RELIGIOSO
10 – 18 GENNAIO – NOVENA
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre
DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA
Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena
Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria
LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO
Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre
Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.
Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono
Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca
IL PROGRAMMA CIVILE
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio
Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.
Stand gastronomici con prodotti tipici.
BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO
Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco
ALTA FREQUENZA LIVE SHOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri
SHOCCHEZZE IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE
Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali
Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio
Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE
Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale
Asta del Santo e dello stendardo
A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO
Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre
Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie
Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
Ore 22:30 – Viale stazione
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro
Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.
Luna Park in Piazza Cuti.
📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
- Il Santo in processione
- Il pittoresco innalzamento dello stendardo
- La pestanaca
Approfondimenti
Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo
Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.
Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.
 Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.
Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.
Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.
Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.
° ° °
 Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.
Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.
Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.
° ° °
I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.
Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.
Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.
Approfondimenti
Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.
La sicurezza e la scelta dei materiali
Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.
L’arte di definire i contorni
L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.
Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti
Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.
L’uso di elementi decorativi a pavimento
Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.
Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo
La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.
Soluzioni pratiche per l’alimentazione
Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.
-

 Alessano4 settimane fa
Alessano4 settimane faMaserati contro Renault sulla statale: perde la vita professore di Alessano
-

 Alessano3 settimane fa
Alessano3 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina
-

 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti
-

 Attualità4 giorni fa
Attualità4 giorni faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faCosa accadrà alla Piscina di Marina Serra?
-

 Attualità4 settimane fa
Attualità4 settimane faTricase: “I bus fermano sulla rotatoria, è progettata male”
-
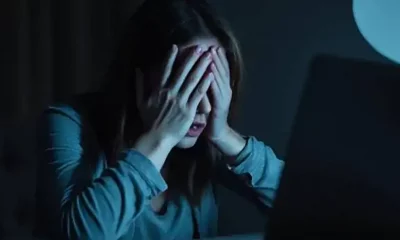
 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane fa“Mia Moglie” su Facebook: il gestore era salentino
















































