Approfondimenti
Letture estive: “I miei compagni di scuola” di Rocco Boccadamo
Nel mio ultimo libro “Zia Valeria”, è compresa una narrazione dal titolo “1952/1960 – Il narrastorie, giovanissimo, alle Medie e alle Superiori”, che qui pubblico, soprattutto, a beneficio di quanti non avessero già avuto modo di leggerla e/o volessero farlo adesso…
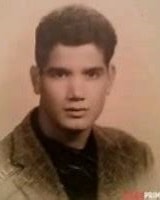
I miei compagni di scuola
Nel mio ultimo libro “Zia Valeria”, è compresa una narrazione dal titolo “1952/1960 – Il narrastorie, giovanissimo, alle Medie e alle Superiori”, che qui pubblico, soprattutto, a beneficio di quanti non avessero già avuto modo di leggerla e/o volessero farlo adesso.
In seno a detta “storia”, rievocativa di un importante aspetto degli anni belli del “ragazzo di ieri”, sono, fra l’altro, indicati i nomi dei compagni delle Superiori, per come, mentre scrivevo, sono riuscito a scorrerli in rassegna, a mente.
Successivamente, invece, ho chiesto e ottenuto dall’Istituto Tecnico Commerciale “Cezzi – De Castro” di Maglie, l’elenco ufficiale della 5^ classe, sezione B, di cui facevo parte, che, pure, accludo.
Dal 1960 al 2024, sono passati ben sessantaquattro anni. Ebbene, a così tanta distanza di tempo, mi è stato dato, con emozione, di ricontattare, risentire e, in alcuni casi, rivedere, una parte dell’antica scolaresca di ragionieri.
In aggiunta, nelle more di poter, più avanti, organizzare un incontro collettivo, ho voluto inviare o consegnare in dono, a tutti i miei compagni, una copia del libro richiamato in apertura.
Tranne, con rammarico, agli undici che, purtroppo, non ci sono più.
*** *** ***
1952/1960, il narrastorie, giovanissimo, alle Medie e alle Superiori
Traggono, insolitamente, abbrivio, le presenti note, da un commento, inerente a una mia narrazione di qualche settimana fa, postatomi via Facebook da Giorgio Ruggeri, originario di Uggiano La Chiesa, per cinque anni compagno di classe, anzi contermine di banco, alle scuole superiori, e, però, mai più rivisto dal lontanissimo 1960: “Hai tanti bei ricordi della tua terra. Mi aspetto qualche pubblicazione di quel mitico Istituto Tecnico di Maglie che abbiamo lasciato nel 1960. Ti saluto”.
Prima di tracciare la specifica rievocazione invocata dall’antico coetaneo e amico, ritengo opportuno soffermarmi su un minuscolo rosario di “pillole” delle mie esperienze scolastiche antecedenti, afferenti, per l’esattezza, al ciclo delle “Medie”.
Invero, conseguita la licenza elementare, mi successero, inanellandosi, una serie di piccoli e però particolari eventi, che lasciarono qualche segno in quelle correlate tenere stagioni. Intanto, iscrittomi per frequentare, a Maglie, il richiamato corso di studi, iniziai concretamente a farlo in un canonico (per l’epoca) 1° ottobre, ricordo, nella sezione “Prima D”, docente di lettere il giovane professore Francesco Erroi. In parallelo, mi sistemai, come “pensionante”, presso una famiglia della cittadina, dove si trovava già, alloggiato in analoga formula, un mio compaesano, nonché parente, il quale attendeva alle lezioni nel locale Liceo classico.
***
Sennonché, scivolate via, sì o no, un paio di settimane, giunse a mio padre, impiegato comunale, la notifica della mia ammissione a un convitto dell’Inadel (Istituto di previdenza per i dipendenti degli enti locali) ubicato ad Anagni (FR), dove, purché fossi stato di anno in anno promosso, avrei potuto compiere l’intero percorso formativo, fino alla maturità o al diploma, in regime completamente gratuito, compresi vitto, alloggio, libri di testo e tasse scolastiche. Peraltro, ad Anagni, nella medesima struttura scolastica dell’Inadel, intitolata al Principe di Piemonte, c’era già, da un biennio, il mio fratello maggiore Antonio. Lasciai, quindi, in fretta e furia, la scuola di Maglie e, accompagnato in treno dal citato genitore, raggiunsi il convitto nella cittadina laziale. Ma la relativa esperienza, nonostante si trattasse di una sistemazione obiettivamente buona in ogni senso, si esaurì, purtroppo, in modo infausto, nel volgere di un risicato arco di tempo. Con la motivazione di non sopportare il distacco dal mio paesello d’origine, dalla mia famiglia e, soprattutto, da mia madre, vissi, o diedi a intendere di vivere, un’autentica tragedia, per cui, in breve, mio padre fu costretto a ripetere il viaggio ad Anagni e a riportarmi a casa. La mia capricciosa ma inamovibile impuntatura fu presa come un autentico smacco non solo in casa, ma pure presso i parenti e fra gli amici compaesani: si pensi, a undici anni e mezzo, mi trovai appiccicata addosso, addirittura, l’etichetta appellativa di “rovina famiglie” e/o mi vidi piovere sul capo l’osservazione “Il Padreterno dà i biscotti a chi non ha denti per mangiarli”. Ma la storia non finisce qui. Difatti, una volta rientrato a Marittima, il piccolo, criticato “reduce” assunse un’ulteriore rigida posizione, facendo cioè presente, con vigore, che non gli andava di far la brutta figura di comparire, in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni, in una classe di Scuola media pubblica, fosse a Maglie o a Tricase.
Di conseguenza, non gli rimase che affidarsi al concittadino maestro delle elementari, Alfredo Quaranta, prendendo a svolgere insieme con lui, ogni pomeriggio, il programma didattico della prima media e sostenendo a Maglie, da privatista, nel successivo giugno, l’esame finale, con esito positivo. La stessa sceneggiata ebbe, purtroppo, a verificarsi in corrispondenza dell’anno scolastico seguente, sebbene io avessi spergiurato che giammai si sarebbe ripetuta la prima infantile rinuncia collegata al convitto. In detta seconda esperienza anagnina, feci in tempo a mandare a quel paese, e anche oltre, l’insegnante di matematica della locale Scuola media. Questi, rivedendomi nella sua 2^ e avendo a mente il mio anticipatissimo abbandono dell’anno precedente, mi chiese dove e come avessi frequentato in alternativa e volle saggiare la mia preparazione con la coppia di domande a bruciapelo “tre per quattro, quanto fa?” e “quattro per tre, quanto fa?”, e, alla mia ripetuta risposta di dodici, fece seguire l’interrogativo trabocchetto scontato “e perché?”.
Da parte mia, sotto agitazione o per un improvviso vuoto di memoria, risposi al secondo problema con un banale “perché è la stessa cosa”, senza minimamente accennare alla regola, men che elementare, della nota proprietà commutativa della moltiplicazione “cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia”. Risate a tutto spiano, se non sghignazzi, dalla bocca del docente, il quale, secondo il sentire infantile, ma non troppo, della vittima, si accaniva su un malcapitato; con l’aggravante, che le sue sfacciate reazioni d’ilarità e di scherno arrivavano immediatamente ad accomunare l’intera scolaresca. Per ciò, non riuscendo a trattenermi, rivolto al professore, io finii con lo sbottare, d’istinto, in un: “Lei è un p….!” (a chiare lettere, secondo Wikipedia, suide addomesticato, che grugnisce). Dopo di che, preso per un braccio dallo stesso autorevole destinatario dell’improperio, verosimilmente colto di sorpresa dalla mia reazione e divenuto paonazzo in volto, mi trovai in un baleno di fronte al preside e, seduta stante, scattò la sospensione, per alcuni giorni, dalle lezioni (poco male, ragionai tra me e me, tanto intendo lasciare questa scuola e tornarmene nel Salento).
***
Finalmente, ci fu da predisporre la frequenza della terza media e, questa volta, niente tergiversazioni su opzioni convittuali ma semplice e diretta iscrizione alla scuola pubblica di Maglie e, guarda caso, nuovamente sezione D e docente di lettere il già citato Francesco Erroi.
Nel complesso, si rivelò del tutto agevole l’esperienza da normale frequentante, con la sola eccezione di talune mie esitazioni, specie all’inizio, nel seguire le lezioni di francese (evidentemente, durante il biennio trascorso in veste di allievo privatista del maestro Alfredo, non avevo assimilato a sufficienza le relative nozioni). Per fortuna, in quel corso della scuola pubblica, c’era un professore molto bravo, anche se dal carattere un tantino particolare, Giuseppe Macrì, il quale, in certo qual modo, mi prese a cuore e, specialmente, mi tenne sotto tiro, giungendo talora – tempi lontani e, ovviamente, agli antipodi rispetto agli attuali – a trascinarmi fino alla lavagna e ad appoggiare lievemente ma ripetutamente la mia fronte sulla relativa lastra nera, sentenziando: “Se non te lo “imparo” io, il francese, non te lo “impara” neppure Domine Dio”. Devo ammettere che la cura del docente Macrì si rivelò efficace.
***
Ottenuta, poi, con buoni voti di profitto, la licenza di Scuola media, si presentò la necessità di scegliere per le Superiori. In cuor mio, pensavo di seguire l’esempio del mio fratello maggiore e di iscrivermi al ginnasio e, a ruota, al liceo classico, oppure, in subordine, forse volendo emulare il mio insegnante elementare, di andare a frequentare l’Istituto magistrale a Lecce. In concreto, però, giunse a prevalere uno sbocco differente, che, in fondo, accettai con convinzione, nell’ottica di vedere agevolato, con quello specifico diploma, l’inserimento nel mondo del lavoro, la conquista di un impiego. Insomma, la scelta cadde sull’Istituto tecnico commerciale statale, indirizzo amministrativo “Cezzi – De Castro” di Maglie, località dove mi sarei portato, da Marittima, con il pullman delle Sud Est, già sperimentato durante la terza media. E alla “Ragioneria”, così si appellava semplicemente e praticamente detto polo d’istruzione, trovai, fra i compagni di classe, Giorgio Ruggeri, menzionato all’inizio di questa narrazione. Si trattò, da subito, di una pratica diversa e accattivante, che si sviluppava non più fra ragazzini bensì fra adolescenti, con discipline da studiare in gran parte inedite. A oltre sessant’anni di distanza, serbo ancora memoria dei nomi dei frequentanti il corso “B”: Eugenio Agnello (Nociglia), Vito Alfarano (Tricase), Salvatore Baglivo (S. Eufemia di Tricase), Rocco Boccadamo (Marittima), Antonio Brocca (Muro Leccese), Francesco Bruni (Otranto), Giovanni Cioffi (Casarano), Antonio Costa (Maglie), Franco De Donatis (Torrepaduli), Luigi De Pascalis (Martano), Antonio De Santis (Martano), Antonio Di Noia (Uggiano La Chiesa), Luigi Filippi (San Cassiano), Antonio Gerardi (Corigliano d’Otranto), Vincenzo Guarino (Corigliano d’Otranto), Franco Latino (Poggiardo), Vincenzo Laurenti (Otranto), Oliviero Leuzzi, (Botrugno), Fernando Lisi (Miggiano), Giorgio Monteduro (San Cassiano), Giuseppe Monteduro (San Cassiano), Antonio Pastore (Cocumola), Franco Pirelli (Leuca), Giovanni Pisanò (Casarano), Ippazio Pulimeno (Corigliano d’Otranto), Gerardo Rizzo (Alessano), Luigi Rizzo (Otranto), Carmine Romano (Maglie), Giorgio Ruggeri (Uggiano La Chiesa), Luigi Rutigliano (Otranto), Giuseppe Schifano (Andrano), Vittorio Velotti (Melissano), Tommaso Vergari (Botrugno), Filippo Vergari (Montesano Salentino), … Vergine(Corigliano d’Otranto). Dei trentasei appena elencati, per la precisione, non tutti erano presenti nel primo anno, alcuni si aggregarono gradualmente nelle classi successive; due o tre compagni, purtroppo, non riuscirono a conseguire puntualmente il diploma, uno, invece, Filippo Vergari, bravissimo, compì un “salto” nel corso dell’anno scolastico, completando gli studi nel 1959, anziché nel 1960. Ricordo pure i nomi del Corpo docente succedutosi in seno al corso “B” durante l’intero ciclo: Luigi Antonica (inglese), Anna Balena (calligrafia), Paolo Congedo (italiano, 2^ e 3^ classe), Salvatore Errico (italiano, 4^ e 5^ classe), Luigi Ferrante (diritto ed economia politica, 5^ classe), Italo Giuri (ragioneria e tecnica, 5^ classe), Concetta Manna (stenografia), Luigia Manno(italiano, 1^ classe), Don Franco Maruccio (religione), Luigi Paolo Mazzotta(computisteria, ragioneria e tecnica, 2^, 3^ e 4^ classe), Laura Orlando (matematica), Stella Rosa (francese), don Francesco Rotundo (religione), Luigi Serio (diritto ed economia politica, 3^ e 4^ classe), Lucia Turco. (scienze naturali, chimica, geografia economica), Giuseppe Valentini (educazione fisica).
Per quanto riguarda la guida complessiva dell’Istituto, affiancavano il preside, Prof. Mario Duma, il segretario (all’inizio, Salvatore Gualtieri, dopo, rag. Domenico Mele) e l’addetto alla segreteria Giacomino De Donno, col prezioso ausilio dei collaboratori scolastici Nino e Ada.
***
Anche in seno alla nuova realtà scolastica, nel giro di poco tempo, mi trovai coinvolto in qualcosa di imprevisto e imprevedibile, relativamente alle lezioni di lingua francese. Malgrado le prima indicate mie carenze in terza media, che avevano richiesto una cura energica da parte del professore Macrì (lo rivedo, negli occasionali fugaci incontri di primo mattino, in Piazza Capece a Maglie, dove aveva sede la Scuola Media in cui egli era rimasto a insegnare, nell’atto di roteare a lungo la mano e il braccio destro, come per dire “eh, cambiando scuola e con la nuova docente che avete trovato all’Istituto Tecnico, vi è andata proprio bene, fate la pacchia”), agli occhi e al giudizio della professoressa Stella Rosa ebbi subito ad apparire come un allievo non bravo ma bravissimo, un esempio; sia nelle interrogazioni, come nei compiti scritti, fui gratificato con una serie di nove e dieci.
In aggiunta a ciò, l’insegnante, a un dato momento, mentre teneva le sue lezioni nella seconda e nella terza “B”, prese l’abitudine di mandarmi a chiamare tramite il bidello Nino, in modo da far vedere agli allievi di quelle classi, chiaramente più grandi di età, con me direttamente presente e fungente da “campione”, come si dovesse studiare e dimostrare di sapere la sua materia. Per me furono, però, circostanze, piuttosto che gratificanti, di disagio e di “vergogna”, anche perché, durante i miei “sconfinamenti” nei corsi superiori, c’era sempre qualcuno che, sottovoce, mi indirizzava l’invito a ritornarmene nella mia classe, invece di prestarmi al gioco della docente. In particolare, al cospetto di studenti/giovanotti o quasi, il mio disagio cresceva durante l’inverno, quando, quattordicenne o poco più, esibivo pantaloni alla zuava e, ai piedi, calzettoni di lana fatti a mano e sandali semiaperti, per via dei fastidiosi geloni che, pur mordendo il freddo, non mi consentivano di infilarmi scarpe chiuse, chiaramente più adatte alla stagione. Tuttavia, come consolazione, negli scrutini finali della prima superiore, sulla pagella, accanto alla materia “Lingua francese”, vidi campeggiare un bel nove.
***
Provo ora a dedicare veloci note aggiuntive, tra il serio e il faceto, su determinati professori.
Luigi Paolo Mazzotta, faceva su e giù, dalla sua residenza a Maglie, alla guida di un’autovettura Fiat 600. Come insegnante, non godeva di eccelsa fama, nondimeno era buono, gioviale e tollerante; di tanto in tanto, aduso a intercalare alla lingua italiana accezioni o frasi dialettali. Il primo compito che ci assegnò in seconda classe, materia, la computisteria, verteva sulla cosiddetta regola “catenaria”. Alle 8, ora di inizio delle lezioni, si era limitato a dettare la traccia dell’esercizio, recandosi, quindi, in un’altra classe in cui aveva lezione e lasciando a vigilare su di noi il collega di una differente disciplina. Ritornato alle 9, compì una rapida ricognizione fra i banchi e si accorse che nessuno aveva iniziato a svolgere il compito, forse perché le sue spiegazioni non erano state sufficientemente chiare alla scolaresca. Al che, si avvicinò a una parete dell’aula e proruppe in un “povero me, non hanno capito niente!”, e, a seguire, ritirò tutti i fogli e annullò la prova. Qualche tempo dopo, si ripetette un caso similare. Io pur cercando di studiare e approfondire per conto mio quella materia, a una verifica presi, come voto, 4, l’unico in tutta la mia carriera scolastica. Rimasi, di conseguenza, avvilito, per alcuni giorni “odiai” il professor Mazzotta, un mattino, incrociandolo casualmente per strada, arrivai addirittura a rinfacciargli ostentatamente, con la mano destra aperta su quattro dita, il brutto voto (per quel gesto, il giorno successivo, il docente mi rimbrottò severamente davanti a tutti i compagni). Negli anni seguenti, mi venne l’idea di aiutarmi con un altro libro, in aggiunta a quello di testo e, in tal modo, riuscii a trovarmi meglio con il docente in questione; quasi quasi, senza che me ne avvedessi, intervenne una sorta di miracolo. A comprova, eravamo in quarta, un giorno fui chiamato alla cattedra per un’interrogazione. “Parlami del conto lavorazione nelle imprese industriali “, mi invitò il professore. All’inizio un po’ timidamente, io provai ad argomentare e di lì a poco, inaspettatamente, notai che il docente, il capo quasi appoggiato sul piano della cattedra, se ne stava rivolto verso di me con lo sguardo fisso, con la bocca semiaperta e mi osservava concentrato e immobile. Mentre io seguitavo a esporre le nozioni che avevo assimilato, a un certo momento, il prof. Mazzotta si girò di scatto verso i compagni che seguivano la mia verifica dai banchi, ingiungendo loro: “State attenti, che parla il professore!”. Furono risate, come di fronte a una comica. Sia come sia, ottenni un buon voto. Dicevo sopra che, in certi frangenti, il prof. Mazzotta indulgeva ad atteggiamenti o a discorsi “alla buona”. Ad esempio, una volta, rivolto a Eugenio Agnello che stava chiacchierando in classe con un compagno, se ne usci con:” Agnello, la vuoi finire o no? Vedi che, se non la smetti, ti appendo”. Naturalmente, pure in questa occasione, ilarità generale, avendo, il prof., configurato l’immagine di un pacifico ovino macellato, appeso a un gancio e pendente sull’uscio di un negozio di carni. In un’altra circostanza, chiamando in causa il compagno Antonio Di Noia: “Noia (n.d.a., cognome in sintesi, al posto di Di Noia), perché ridi?”. Risposta del ragazzo: “Professore, è Agnello che mi fa ridere”. Replica conclusiva: “E tu, non ti fare ridere”. In quarta classe, il sabato, avevamo lezione, con il prof. Mazzotta, dalle 12 alle 13. Or bene, con l’intraprendenza da ragazzi ormai grandicelli, pensammo di prendere la licenza, approfittando dell’intervallo per il cambio di insegnante a mezzogiorno, di svignarcela, prima che il docente Mazzotta giungesse da noi. Era brevissimo il percorso fra la nostra aula e il portone l’uscita della scuola, anche se si doveva passare davanti alla porta della presidenza. Partendo da quell’idea, ponemmo ripetutamente in atto l’alleggerimento dell’orario didattico del sabato, anche se capitava di sentire dal prof. Mazzotta, in arrivo, “dove andate?” e dal preside “siete impazziti, che fate, rientrate in classe”. Tutto inutile, la fiumana della quarta “B” era ormai, in maggioranza, per strada. In fondo, il nostro pensiero autoassolutorio era che rendevamo un favore all’insegnante, consentendogli di ritornare nella sua residenza, in anticipo rispetto al previsto. Saltando dagli anni Cinquanta del secolo scorso al 2000 circa, ho avuto modo di contattare e rivedere a Lecce il professor Luigi Paolo Mazzotta, il quale si è ricordato subito del suo allievo, Boccadamo da Marittima (“eri uno bravo, vero?”, mi ha chiesto al telefono). Su suo invito ci siamo incontrati al Bar Manhattan, consumando un’aranciata amara in due e, infine, mi ha brevemente accolto nella sua abitazione nelle vicinanze. Non molto tempo fa, ho saputo che il professor Mazzotta se n’è andato, ultranovantenne.
La professoressa di matematica, Laura Orlando, era molto brava e preparata, come persona, secondo il mio giudizio di adolescente, lasciava, invece, un po’ a desiderare, andava per simpatia e io, nonostante me la cavassi bene anche nella sua disciplina, non rientravo nel novero degli allievi prediletti. Giovane, nubile, portava spessissime lenti. Quando dovevamo svolgere compiti in classe, la sua prima azione era di farmi lasciare il banco dove ero seduto abitualmente insieme a un compagno e di invitarmi a sedere, a solo, in un banchetto accanto alla cattedra. Quindi, dettava due tracce: una, per gli allievi che si trovavano nella parte destra di ciascuna fila di banchi e l’altra, per i restanti che avevano posto nella parte sinistra. Io, anche se l’insegnante mi diceva di svolgere una ben determinata prova, mi annotavo tutte e due le tracce, le valutavo e svolgevo quella che mi sembrava più facile. Il trucchetto funzionava quasi sempre. Solamente in un caso, si scoprirono gli altarini, allorquando la prova “tosta”, che sarebbe toccata anche a me, non fu svolta da alcuno della scolaresca: la docente trasse spunto da ciò, per fare mente locale, dopo di che mi rinfacciò, rimproverandomi, il giochetto posto in atto e annullò la prova.
In quarta, studiavamo la matematica finanziaria e attuariale, un vero e proprio calvario di formule da imparare e tenere a memoria. Riflettendo sulla limitazione visiva della Orlando, escogitai di copiare, con una matita o lapis, sul nero della lavagna, ovviamente in ore vuote o favorevoli, la maggior parte delle formule in questione, che la prof., anche mentre spiegava avvicinandosi alla lavagna, non riusciva a notare. Al contrario, noi allievi, quando eravamo interrogati, alla richiesta di riferire la formula A o B dicevamo: “Prof., posso scriverla alla lavagna?”. Così, spesso riuscivamo ad aiutarci. La trovata funzionò per lungo tempo.
Il professore di italiano Paolo Congedo (seconda e terza classe) era un docente eccezionale, di poche parole, ma di profondissima cultura e vasta esperienza. Durante le spiegazioni, lo seguivamo in assoluto, quasi religioso silenzio e con molta attenzione. Severo ma anche giusto, disponibile nelle interrogazioni e nelle verifiche in genere. In quarta e in quinta, arrivò, al suo posto, il professor Salvatore Errico, il quale, inizialmente, sembrò soffrire un po’ per la difficile successione; la stessa scolaresca, ovviamente, accuso la differenza e, tuttavia, non tardò a adattarsi e a integrarsi col nuovo docente, peraltro persona dal tratto ottimo e alla mano.
L’avvocato Luigi Ferrante, di ottima e nobile famiglia, docente di diritto ed economia in quinta classe, era una pasta d’uomo, un signore; ci lasciava un po’ fare e noi, purtroppo, lo ripagavamo con qualche intemperanza. Per citare, mentre lui parlava, accendevamo in classe una radiolina e, quando la stessa emetteva i classici fischi che precedono l’inizio di un programma, non poteva non accorgersi del suono, che noi sostenevamo, impunemente, dovesse attribuirsi al cinguettio degli uccellini sugli alberi d’arancio del giardino confinante con la scuola. Ancora, da poco avevo scelto di andare a sedermi all’ultimo banco accanto a Giorgio Monteduro, detto “palo” perché di altezza prossima ai due metri, a un certo punto proposi, ai vicini di banco, l’idea di vivacizzare le lezioni del professor Ferrante.
Approfittando dell’esistenza di una stufa per riscaldamento che, abitualmente, si trovava in fondo all’aula, proposi di cucinare qualcosa, appunto, durante l’ora del professore Ferrante, ad esempio due uova. Dalle parole ai fatti: chi portò una padellina, chi olio e sale, chi, secondo ricetta, un paio di uova fresche. Mentre il professore spiegava, la stufa fu inclinata con l’ampio piatto in posizione orizzontale, la padellina con l’olio posata sulla fiamma; al cadere sull’olio bollente, le uova emisero il classico sfrigolio, il professore sentì lo strano “rumore”, agitandosi e chiedendo di colpo “che cosa stesse succedendo laggiù”. Gli improvvidi cucinieri provarono rapidamente a smontare e disattivare l’apparato, ma, ovviamente, l’avvocato Ferrante si accorse di tutto, senza però farne una tragedia. Diversamente, il mattino seguente, prima dell’inizio delle lezioni, sulla Quinta “B”, si abbattette la violenta ramanzina del bidello Nino, il quale, imprecando all’indirizzo dell’intera scolaresca per la malefatta, si lamentò, specialmente, di aver dovuto lavorare a lungo per ripulire il pavimento dai residui dell’olio e delle uova rimaste non cotte.
Dopo il triennio di docenza del professor Luigi Paolo Mazzotta, in quinta, per ragioneria e tecnica, ci arrivò il professore Italo Giuri, giovane, piccolo di statura, capelli color biondo rossiccio, occhi verdi, accompagnato da nomea di ottimo insegnante, ma, nello stesso tempo, in barba all’età, di persona austera, molto esigente e severa. Dire che, noi del corso “B”, quanto a bagaglio di preparazione pregressa, non eravamo messi propriamente bene. Iniziò l’esperienza con il professor Giuri, i fatti confermarono subito la presentazione iniziale, in occasione delle verifiche, come voto, si affacciavano anche alcuni due o tre; così, un giorno, era toccato al compagno Vito Alfarano, il quale, rimasto ovviamente male per l’esito della prova, se ne ritornò al banco, seminando, vocalmente, sequenze di imprecazioni e di minacce indirizzate al prof. Giuri. Improvvisamente, si presentò una scena originale e quasi patetica, il docente, eretto sulla pedana della cattedra, con le braccia aperte a configurare una sorta di Santa Croce, ad esclamare: “Non ho paura delle minacce, anzi sono pronto al sacrificio”.
Intorno a Natale 1959, si sparse la voce che il prof. Giuri sarebbe stato il componente interno nella commissione degli esami di maturità. A tale notizia, noi tutti restammo sconcertati e commentavamo “se sarà nominato lui, anziché aiutarci, con la sua severità ci danneggerà se non, addirittura, rovinerà”. In quel periodo, io, nel pomeriggio, studiavo insieme con Franco Pirelli e Franco De Donatis, nell’abitazione presa in affitto a Maglie, per tutto il periodo dell’anno scolastico, dai genitori del secondo compagno di cui sopra. Di fronte alla prospettiva Giuri agli esami di Stato, l’anzidetto terzetto di interessati, pensò a un’iniziativa: scrivere al professore una lettera in bianco, consigliandogli di non accettare, per il suo bene, l’incarico di membro interno. Detto fatto, la missiva fu vergata, con uso, non solamente della penna ma pure di guanti per non lasciare tracce sul foglio e sulla busta, e spedita. Dopo un paio di giorni, mentre stavamo svolgendo in classe un compito proprio col professor Giuri, bussò alla porta dell’aula il bidello Nino: “Dottore, c’è una lettera per lei”. Il destinatario, stupito, prese in mano il plico e, pur seguitando a sorvegliare, al solito, fra i banchi, onde controllare che qualcuno non copiasse dai compagni, lo dischiuse e diede velocemente una scorsa al contenuto. “Molto bene!”, fu la sua ostentata osservazione. Intanto, io e i coautori dell’operazione, ce ne stavamo a capo chino sul banco. Nei giorni successivi, tuttavia, ritornammo arditi, domandando, al docente, se fossero vere le voci sull’argomento. Ma lui replicò con forza: “Non è niente vero, sono notizie destituite di ogni fondamento”. E continuando: “Poi, voi stessi, forse, non mi vorreste come membro interno” e, puntando il dito e lo sguardo verso di me:” Proprio lei, probabilmente, non mi vorrebbe”. Era duro mantenere la compostezza e far finta di niente. Di fatto, il prof. Giuri fu designato come commissario interno alle prove di maturità. Nell’ultimo giorno di lezioni, io trascorsi la mattinata in segreteria, per copiarmi in chiaro i programmi di tutte le materie. Dopo qualche ora, nel cortile della scuola, incrociai il prof. Giuri con molti registri di classe sottobraccio, che mi chiese dove fossi stato invece di essere presente in classe, aggiungendo quindi: “Si è persa un’occasione importante e irripetibile, nonostante le difficoltà e i contrasti relazionali nel corso dell’anno, oggi, nella Quinta “B”, c’è stata un’assemblea immemorabile, commossa, abbiamo tutti pianto per il commiato”. E, dopo, mi invitò a seguirlo in un’aula, per dettargli le assenze degli alunni da riportarsi nella pagina degli scrutini di fine anno.
In realtà, in mia presenza, a dimostrazione inaspettata della fiducia che riponeva in me, egli fece gli scrutini: di promozione o meno per le classi intermedie e ai fini dell’ammissione o meno agli esami di Stato, per la mia classe Quinta “B”. Giunto al mio nome, disse: “La ammetto con sette e sette (in ragioneria e in tecnica), ma guai a lei se, agli esami, non riporterà un voto migliore”. Giunsero le prove conclusive, scritte e orali; in occasione delle seconde, mi toccò un’interrogazione di circa un’ora, fortunatamente risposi a tutti, notando, man mano, come sul volto del mio insegnante andassero vieppiù a stamparsi le impronte di una grande soddisfazione.
Dopo una decina di giorni, fui informato che erano usciti i “quadri”, lo dissi immediatamente a mio padre e, con un’autovettura presa a noleggio, ci recammo insieme a Maglie. All’ingresso dell’Istituto, prima ancora di avvicinarci ai fogli con i risultati degli esami, incontrammo il segretario Mimì Mele, il quale, con un sorriso, mi fece: “Hai preso voti tutti tondi, complimenti”, volendo dire otto e nove. Così lessi, in effetti, sui “quadri”; in particolare, nelle materie ragioneria e tecnica del Prof. Giuri, avevo riportato un bellissimo nove. I miei, erano i migliori voti di tutto l’Istituto e, come seppi dopo, si collocavano ai più alti livelli pure su scala provinciale.
Come avvenuto con riferimento al prof. Luigi Paolo Mazzotta, intorno al 2000, ho chiesto e ottenuto di rivedere anche il professor Italo Giuri. Commovente il clima dell’accoglienza, contraddistinto da un particolare; quando gli ricordai che agli esami di maturità mi aveva messo nove in entrambe le sue materie, il docente rimase allibito e chiamò immediatamente la moglie, già sua allieva, dicendole: “Senti, questo signore mi sta rammentando che, agli esami di Stato, gli ho dato 9 nelle mie due materie” e la consorte:” Sembra proprio impossibile, già che, quando tu assegnavi un sei o un sei e mezzo, si era proprio al massimo”.
Avviandomi alla conclusione, non posso non dedicare una serie di piccoli dettagli o particolari ai miei cari compagni delle Superiori.
Il già menzionato Vito Alfarano aveva un amico straordinario, quasi un gemello, Salvatore Baglivo, prendevano insieme, da una vita, il treno Tricase – Maglie e viceversa, si scorgevano ovunque e sempre insieme, appariva nitido e inequivocabile che si volevano molto bene, erano affiatati, guai a parlare, all’uno, male dell’altro o viceversa: anche se, spesso, Alfarano sovrastava il secondo con iniziative, diciamo così, vivaci. Era solito, Totò Baglivo, dotarsi di quaderni di grosso formato, se non che, nel giro di pochi giorni, gli stessi erano ridotti alla misura più minuscola, del costo di cinque o dieci lire a pezzo, in quanto Vito glieli sfogliava di nascosto; beninteso, sfogliava, nel senso che gli strappava le pagine per utilizzarle lui. La vittima si lagnava di ciò, ma solo per un attimo.
Alfarano era il soggetto che serbava gelosamente, nel portamonete, un foglietto con la brutta copia di un tema assegnatogli e svolto alle Elementari, “La mia mamma”.
Non avendo moltissima voglia di applicarsi nello studio, egli, al fine di aiutarsi, soleva, durante tutto il corso di studi, comprese le Superiori, copiare una parte di quell’antico componimento, in tutti i compiti che era chiamato a svolgere, qualsivoglia fosse la traccia e l’argomento. Detta pratica di Alfarano era nota agli insegnanti di lettere di mezza Terra d’Otranto.
Negli ultimi mesi scolastici della quinta classe, io, anziché restarmene in pensione presso una famiglia a Maglie, decisi di ritornare a fare il pendolare, in treno. Venuto a conoscenza della novità, Alfarano mi diffido dal comprare l’abbonamento con le Ferrovie Sud Est, dicendomi: “Tu chiederai i soldi ai tuoi genitori, ma gli userai, di fatto, esclusivamente per l’acquisto di sigarette, così fumiamo alla grande; intanto, durante i tragitti in treno, sarai sotto la nostra protezione, non ti preoccupare, già che conosciamo tutti i controllori delle Sud Est, anzi siamo loro amici”.
Adesso, sento di dover indirizzare un pensiero ad Antonio Brocca, detto, bonariamente, “la morte”, a causa del suo viso particolarmente e perennemente pallido. Un certo giorno, mi frullò l’estro di scagliare verso di lui il cancellino, intriso di gesso, che si adoperava alla lavagna, lo raggiunsi proprio sul viso, al che, il poveretto, dopo essersi accorto che ero stato io, corse lesto in direzione della presidenza e ritornò nella nostra classe insieme con il capo dell’Istituto, il quale mi intimò: “Vai immediatamente fuori!” e io, ubbidendo, me ne andai nel giardino/palestra della scuola.
Del gruppo di otrantini, il più benvoluto dall’intera scolaresca era Luigi Rizzo, i cui genitori avevano un negozio di generi alimentari, cosicché, Gigi, arrivava ogni giorno in classe con un bel panino imbottito, che, cuore alla mano e generosità grande, per l’intero anno scolastico, non vi fu una volta che lo mangiò da solo.
Una peculiarità, relativamente ai due martanesi Luigi De Pascalis e Antonio De Santis: durante le interrogazioni, provavano, talora riuscendo, ad aiutarsi l’un l’altro, mediante suggerimenti in “grico”.
Non me ne vogliano i restanti compagni, se non li rievoco, nelle presenti righe, uno per uno, ma tengo a dire che, di tutti gli iscritti al corso “B”., singolarmente e distintamente, serbo un vivido ricordo nella mia mente e dentro l’animo. E provo, ancora adesso, sentimenti di spiccata, sincera ammirazione per quanti di loro frequentavano l’Istituto sottoponendosi, quotidianamente, a una notevole fatica, per coprire, in bicicletta, il percorso dai rispettivi paesi a Maglie.
Una volta esauritasi la mia attività lavorativa e rientrato nel Salento, ho avuto agio di rivedere di persona alcuni compagni, invero pochi e ciò mi dispiace: Franco Pirelli, Franco De Donatis, Luigi De Pascalis, Antonio De Santis, Claudio Calzolaro, Giovanni Cioffi e Fernando Lisi.
Un ricordo speciale e commosso, infine, desidero innalzare a Salvatore Baglivo, il quale, l’ho saputo dopo, una ventina d’anni fa, ancora giovane, è stato purtroppo coinvolto, rimanendone vittima, in un incidente stradale sulla via che da Tricase conduce a Tricase Porto.
***
La mia primavera scolastica, specialmente il quinquennio delle Superiori, mi ha dato molto, formandomi e educandomi all’impegno in senso generale e alla ricerca e coltivazione di buoni rapporti con gli altri, consentendomi, in definitiva, di crescere. Sono, in particolare, fiero per i cordiali, amichevoli e quasi fraterni legami intrattenuti costantemente con tutti i miei compagni, nessuno escluso, e anche per la positiva interazione avuta con il Corpo docente e il restante personale dell’Istituto.
Si è trattato, non soltanto di una scuola didattica in senso strettamente culturale ma, pure, di una preziosa e insostituibile palestra di vita, in cui ho cercato di svolgere con umiltà e, insieme, con intensità, la mia parte, trovandomi sempre bene: dare agli altri, ma anche prendere dalle loro doti positive e dal loro buon esempio.
Da ultimo, ma non perché rivesta minore importanza, confesso che mi sono anche sanamente divertito.
Rocco Boccadamo
Approfondimenti
Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento
Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.
Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.
Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.
Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.
Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.
Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.
Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.
Si entrerà nel vivo domenica 18.
Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.
Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.
Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.
Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.
Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.
Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.
Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ
Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.
In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.
Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.
Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.
La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.
Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.
Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.
La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.
Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.
Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.
Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.
IL PROGRAMMA RELIGIOSO
10 – 18 GENNAIO – NOVENA
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre
DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA
Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena
Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria
LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO
Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre
Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.
Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono
Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca
IL PROGRAMMA CIVILE
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio
Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.
Stand gastronomici con prodotti tipici.
BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO
Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco
ALTA FREQUENZA LIVE SHOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri
SHOCCHEZZE IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE
Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali
Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio
Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE
Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale
Asta del Santo e dello stendardo
A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO
Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre
Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie
Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
Ore 22:30 – Viale stazione
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro
Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.
Luna Park in Piazza Cuti.
📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
- Il Santo in processione
- Il pittoresco innalzamento dello stendardo
- La pestanaca
Approfondimenti
Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo
Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.
Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.
 Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.
Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.
Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.
Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.
° ° °
 Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.
Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.
Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.
° ° °
I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.
Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.
Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.
Approfondimenti
Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.
La sicurezza e la scelta dei materiali
Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.
L’arte di definire i contorni
L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.
Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti
Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.
L’uso di elementi decorativi a pavimento
Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.
Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo
La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.
Soluzioni pratiche per l’alimentazione
Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.
-

 Alessano4 settimane fa
Alessano4 settimane faMaserati contro Renault sulla statale: perde la vita professore di Alessano
-

 Alessano3 settimane fa
Alessano3 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina
-

 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti
-
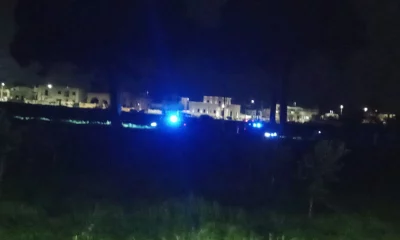
 Attualità3 giorni fa
Attualità3 giorni faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faCosa accadrà alla Piscina di Marina Serra?
-

 Attualità4 settimane fa
Attualità4 settimane faTricase: “I bus fermano sulla rotatoria, è progettata male”
-
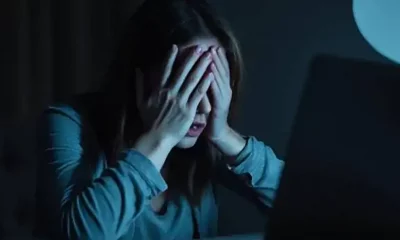
 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane fa“Mia Moglie” su Facebook: il gestore era salentino





























