Approfondimenti
Il Salento che “imposta” il turismo
Il contributo che pagano i turisti ai nostri Comuni per ogni pernottamento, da Otranto a Ugento

Viaggiare non è più solo una passione o un hobby. Il turismo, complici i tempi che corrono, sta diventando un lusso che sempre meno fortunati si possono permettere. Spesso chi parte, tira grossomodo le somme prima ancora di far le valigie. E sa di dover fare i conti, in sempre più città del mondo, con le tasse di soggiorno che governi locali o nazionali chiedono al turista.
Ma quanti di noi salentini, sempre più popolo ospitante che di vacanzieri, sanno che anche alcuni dei nostri Comuni, alla stregua di grandi capitali e città d’arte, richiedono una tassa sul pernottamento? In Puglia, è il caso di 35 località, in cui rientrano anche Santa Cesarea Terme, Otranto, Castrignano del Capo, Patù, Salve ed Ugento.
 Questi Comuni si sono avvalsi della facoltà di introdurre una imposta di soggiorno, concessa dalla legge sul federalismo fiscale del 2011. In realtà, tassare il turismo non è un’idea del terzo millennio: già in passato in Italia esisteva questo tipo di imposta e la nostra Santa Cesarea, da sempre nota meta termale, è tra le prime in Puglia ad averla introdotta nel lontano 1923, salvo poi doverla eliminare quando il Governo centrale, agli albori degli anni ’90, decise di abolirla.
Questi Comuni si sono avvalsi della facoltà di introdurre una imposta di soggiorno, concessa dalla legge sul federalismo fiscale del 2011. In realtà, tassare il turismo non è un’idea del terzo millennio: già in passato in Italia esisteva questo tipo di imposta e la nostra Santa Cesarea, da sempre nota meta termale, è tra le prime in Puglia ad averla introdotta nel lontano 1923, salvo poi doverla eliminare quando il Governo centrale, agli albori degli anni ’90, decise di abolirla.
Non tutti i Comuni possono però richiedere questo contributo al turista, e soprattutto non possono farlo in maniera del tutto libera. Possono pretenderla solo capoluoghi di provincia, unioni di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o citta d’arte. Inoltre, il tetto massimo dell’imposta, che si misura per pernottamento (e prevede una serie di esenzioni, dai portatori di handicap, alle forze dell’ordine, dagli autisti di autobus alle scolaresche, ecc) è di 5 euro a persona a notte.
La filosofia di questo tipo di tassa si basa sulla convinzione che il turista debba contribuire alle spese che il Comune affronta per garantire servizi di cui fruisce. L’esistenza di questo dazio moderno è però tutt’altro che condivisa: Federalberghi e Hotrec (l’Associazione Europea degli hotel e dei ristoratori) su tutte, sostengono il malcontento delle strutture ricettive che vedono in questa imposta un rischio di perdere potenziali clienti. La principale motivazione addotta nella ferma lotta che portano avanti, sta nell’indotto che il turista porta con sé anche senza la necessità di contribuire in maniera diretta: dall’acquistare un caffè ed un quotidiano, sino al fruire di un parcheggio pubblico a pagamento, si creano introiti che, in un modo o nell’altro, portano soldi nelle casse del Comune.
La verità, quasi sempre, sta nel mezzo. Se è vero, come è vero, che turismo è sinonimo di maggior impiego, maggior reddito e via dicendo, è anche innegabile che per i nostri Comuni, in ricorrente affanno, una fonte di sostegno in più non guasta. L’utilizzo degli introiti derivanti dalla tassa sul pernotto, tra l’altro, è vincolato proprio alla sfera turistica. È il d.lgs. 23/2011 a prevederlo, destinando l’imposta al finanziamento di interventi in materia di turismo, che però, secondo i detrattori, esulano troppo spesso in generiche attività di manutenzione o recupero di beni culturali che, più che con l’accoglienza e la valorizzazione del territorio, hanno a che fare con il risanamento di bilanci in rosso.
Se è questo il caso dei nostri Comuni, non ci è dato saperlo, ma ci siamo comunque chiesti a cosa va incontro il turista che sceglie le nostra località sottoposte a questo tipo di contributo e quanto l’imposta di soggiorno frutti ai nostri paesi.
L’imposta di soggiorno nei nosti Comuni
Santa Cesarea Terme come nel 1923
Oltre ad essere, come detto in precedenza, tra le prime località pugliesi ad aver introdotto l’imposta, Santa Cesarea presenta un’altra singolarità: è tra i Comuni il cui territorio non è interamente inteso dalla Regione a vocazione turistica. Nonostante quindi i 13,5 km di litorale, vi devono corrispondere la tassa solo i turisti che pernottano nel centro storico o nelle frazioni di Vitigliano e Cerfignano.
 Il “contributo alla bellezza del territorio” è richiesto, a persona, solo per i primi 5 giorni e varia, a seconda del tenore della struttura scelta, da un minimo di 1 euro ad un massimo di 1,50. Oltre alle esenzioni previste dalla legge, non pagano i minori di 14 anni e la tassa si versa dal 1° aprile al 30 ottobre. Un mese in più rispetto al 2014 (anno in cui è stata reintrodotta) che ha contribuito alla crescita degli introiti di circa 20mila euro: nel 2015, dai 49mila dell’anno prima, si è saliti a 69mila euro. Le strutture in cui si versa la tassa di pernottamento sono in aumento: un anno fa erano 34, quest’anno se ne prevedono a breve 36, anche grazie alla nascita di un nuovo hotel a 4 stelle. Il Comune garantisce al turista sconti e vantaggi e, come indicato dalla legge, reinveste questi fondi in ambito turistico. Tra le altre cose, realizzando eventi per la stagione estiva e garantendo un servizio navetta da e per le frazioni.
Il “contributo alla bellezza del territorio” è richiesto, a persona, solo per i primi 5 giorni e varia, a seconda del tenore della struttura scelta, da un minimo di 1 euro ad un massimo di 1,50. Oltre alle esenzioni previste dalla legge, non pagano i minori di 14 anni e la tassa si versa dal 1° aprile al 30 ottobre. Un mese in più rispetto al 2014 (anno in cui è stata reintrodotta) che ha contribuito alla crescita degli introiti di circa 20mila euro: nel 2015, dai 49mila dell’anno prima, si è saliti a 69mila euro. Le strutture in cui si versa la tassa di pernottamento sono in aumento: un anno fa erano 34, quest’anno se ne prevedono a breve 36, anche grazie alla nascita di un nuovo hotel a 4 stelle. Il Comune garantisce al turista sconti e vantaggi e, come indicato dalla legge, reinveste questi fondi in ambito turistico. Tra le altre cose, realizzando eventi per la stagione estiva e garantendo un servizio navetta da e per le frazioni.
Il milione di Otranto
Con la sua storia, la sua bellezza e il suo appeal, Otranto è tra le mete più gettonate del Salento e per questo anche tra le più ricche. Alla città più a est d’Italia, la tassa di soggiorno nel 2015 ha fruttato 700mila euro, arrivati nelle casse del Comune dalle 200 strutture ricettive registrate, che offrono ai viaggiatori circa 20mila posti letto.
 Chi sceglie Otranto, o i suoi 24 km di costa in cui ricadono anche meravigliose località come Porto Badisco, paga, dal 1° aprile al 30 settembre, un contributo che va da 1 a 3 euro e varia, oltre che a seconda della struttura, anche in funzione del periodo. Dal settimo giorno in poi, si è esentati dal pagamento. Mentre lo sono sempre, oltre alle categorie protette, anche minorenni e tutti coloro che pernottano presso ostelli della gioventù. Nell’estate 2015 Otranto ha contato circa 750mila presenze registrate che, se sommate a chi ci arriva da ospite da amici e parenti, con tutta probabilità sforano il milione.
Chi sceglie Otranto, o i suoi 24 km di costa in cui ricadono anche meravigliose località come Porto Badisco, paga, dal 1° aprile al 30 settembre, un contributo che va da 1 a 3 euro e varia, oltre che a seconda della struttura, anche in funzione del periodo. Dal settimo giorno in poi, si è esentati dal pagamento. Mentre lo sono sempre, oltre alle categorie protette, anche minorenni e tutti coloro che pernottano presso ostelli della gioventù. Nell’estate 2015 Otranto ha contato circa 750mila presenze registrate che, se sommate a chi ci arriva da ospite da amici e parenti, con tutta probabilità sforano il milione.
Numeri già in crescita che il Comune prova ad incrementare ulteriormente nell’unico modo possibile: davanti alla saturazione della città nei periodi più caldi, si punta alla destagionalizzazione del turismo. A chiunque è tenuto a versare l’imposta, inoltre, è garantita la “Otranto Card”, che consente di fruire a prezzi scontati o gratuitamente di alcuni servizi pubblici e di beneficiare anche di uno sconto pari al 10% presso alcuni esercizi commerciali convenzionati.
Castrignano del Capo: De Finibus Tributi
 Storica meta di villeggiatura, nostrana e forestiera, Santa Maria di Leuca fa le fortune del Comune di Castrignano del Capo. Le migliaia di turisti che ogni anno raggiungono il Santuario e pernottano tra Punta Ristola, Punta Meliso e Castrignano, pagano al Comune dai 50 centesimi fino ai 2 euro a notte, a seconda del tipo di struttura scelta. Castrignano è, tra i Comuni presi in analisi, quello dove la tassa va pagata più a lungo: non si è esentati prima del decimo pernottamento consecutivo.
Storica meta di villeggiatura, nostrana e forestiera, Santa Maria di Leuca fa le fortune del Comune di Castrignano del Capo. Le migliaia di turisti che ogni anno raggiungono il Santuario e pernottano tra Punta Ristola, Punta Meliso e Castrignano, pagano al Comune dai 50 centesimi fino ai 2 euro a notte, a seconda del tipo di struttura scelta. Castrignano è, tra i Comuni presi in analisi, quello dove la tassa va pagata più a lungo: non si è esentati prima del decimo pernottamento consecutivo.
Qui l’imposta è stata introdotto il 22 maggio del 2014 e non è richiesta ai minori di 12 anni, ai malati ed ai loro accompagnatori, ed alle categorie indicate dal decreto legislativo istituente la tassa. I numeri su presenze, strutture ricettive e benefici tratti dal Comune mediante l’imposta, non ci sono stati forniti.
Patù: gabella da un anno
Anche Patù ha scelto di valorizzare le sue bellezze introducendo l’imposta di soggiorno.
 Chi sceglie di pernottare qui, godendo del meraviglioso mare di San Gregorio o della spiaggia di Felloniche, deve corrispondere un contributo per le prime 7 notti. La misura dell’imposta va dai 50 centesimi di camper e campeggi ai 2 euro delle strutture alberghiere di lusso a 5 stelle.
Chi sceglie di pernottare qui, godendo del meraviglioso mare di San Gregorio o della spiaggia di Felloniche, deve corrispondere un contributo per le prime 7 notti. La misura dell’imposta va dai 50 centesimi di camper e campeggi ai 2 euro delle strutture alberghiere di lusso a 5 stelle.
Esenti i minori di 12 anni, mentre alcune categorie, come gli sportivi sotto i 16 anni, godono di uno sconto del 30%. Il Consiglio Comunale di Patù (appena rinnovato dalle recenti amministrative) l’ha introdotta un anno fa, con una delibera del 27 maggio 2015. Dati sulle presenze e sugli introiti derivanti dalla tassa, però, non sono al momento disponibili.
Salve e le spiagge…d’oro
Con le spiagge di Posto Vecchio, Pescoluse, Torre Pali e, in piccola parte, Lido Marini, il Comune di Salve è sempre più amato dai turisti di tutto il mondo. Otto chilometri di costa e di attività ricettive che attirano in media 140mila presenze (con pernottamento) all’anno. Qui, per un massimo di 7 giorni consecutivi, si pagano dai 90 centesimi ad 1,80 euro a notte (con portatori di handicap ed altre categorie previste dal decreto legislativo, sono esentati anche tutti i minori di 18 anni). Contributi che la scorsa estate hanno portato nelle casse comunali 65mila euro.
Otto chilometri di costa e di attività ricettive che attirano in media 140mila presenze (con pernottamento) all’anno. Qui, per un massimo di 7 giorni consecutivi, si pagano dai 90 centesimi ad 1,80 euro a notte (con portatori di handicap ed altre categorie previste dal decreto legislativo, sono esentati anche tutti i minori di 18 anni). Contributi che la scorsa estate hanno portato nelle casse comunali 65mila euro.
Non fondi da capogiro, ma per un piccolo Comune come Salve sostegno importante al mantenimento delle bellezze di località che, in passato, hanno più volte raccolto anche il massimo riconoscimento delle “5 Vele” di Legambiente.
Ugento: 1,5 milioni in 4 stagioni
I 13km di costa di Lido Marini, Torre Mozza e Torre San Giovanni, sono da sempre per Ugento un valore aggiunto alla cittadina, il cui odierno centro è la trasposizione nei secoli di uno dei principali insediamenti messapici e municipi d’epoca romana della penisola salentina.
 Il turismo, oggi, nella città della Diocesi del Capo di Leuca, è una delle principali fonti di introito. Il Comune, dalle 61 strutture ricettive, ha ricavato, lo scorso anno, 380mila euro. In linea con le tre estati precedenti in cui, dall’istituzione dell’imposta nel 2012, sono entrati rispettivamente 370, 390 e 370mila euro.
Il turismo, oggi, nella città della Diocesi del Capo di Leuca, è una delle principali fonti di introito. Il Comune, dalle 61 strutture ricettive, ha ricavato, lo scorso anno, 380mila euro. In linea con le tre estati precedenti in cui, dall’istituzione dell’imposta nel 2012, sono entrati rispettivamente 370, 390 e 370mila euro.
Per massimo 7 giorni consecutivi, tra il 15 giugno e il 15 settembre, i maggiori di 13 anni pagano dai 50 centesimi ai 2 euro a notte, a seconda del livello di accoglienza in cui è classificata la struttura scelta.
Lorenzo Zito
Approfondimenti
Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento
Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.
Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.
Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.
Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.
Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.
Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.
Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.
Si entrerà nel vivo domenica 18.
Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.
Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.
Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.
Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.
Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.
Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.
Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ
Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.
In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.
Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.
Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.
La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.
Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.
Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.
La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.
Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.
Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.
Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.
IL PROGRAMMA RELIGIOSO
10 – 18 GENNAIO – NOVENA
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre
DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA
Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena
Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria
LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO
Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre
Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.
Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono
Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca
IL PROGRAMMA CIVILE
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio
Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.
Stand gastronomici con prodotti tipici.
BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO
Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco
ALTA FREQUENZA LIVE SHOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri
SHOCCHEZZE IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE
Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali
Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio
Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE
Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale
Asta del Santo e dello stendardo
A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO
Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre
Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie
Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
Ore 22:30 – Viale stazione
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro
Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.
Luna Park in Piazza Cuti.
📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
- Il Santo in processione
- Il pittoresco innalzamento dello stendardo
- La pestanaca
Approfondimenti
Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo
Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.
Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.
 Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.
Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.
Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.
Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.
° ° °
 Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.
Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.
Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.
° ° °
I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.
Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.
Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.
Approfondimenti
Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.
La sicurezza e la scelta dei materiali
Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.
L’arte di definire i contorni
L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.
Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti
Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.
L’uso di elementi decorativi a pavimento
Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.
Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo
La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.
Soluzioni pratiche per l’alimentazione
Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.
-

 Alessano4 settimane fa
Alessano4 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti
-
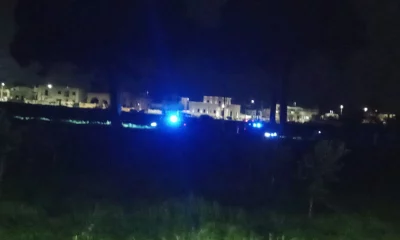
 Attualità6 giorni fa
Attualità6 giorni faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faCosa accadrà alla Piscina di Marina Serra?
-
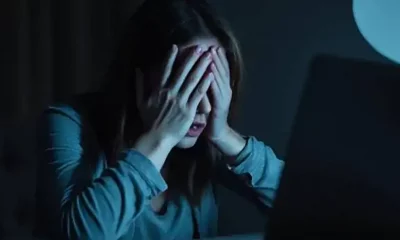
 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane fa“Mia Moglie” su Facebook: il gestore era salentino
-

 Alessano5 giorni fa
Alessano5 giorni faTempesta di vento si abbatte sul Salento, danni e paura a Tricase e Alessano
-

 Alessano3 settimane fa
Alessano3 settimane faSpacciavano da casa, arrestati








































